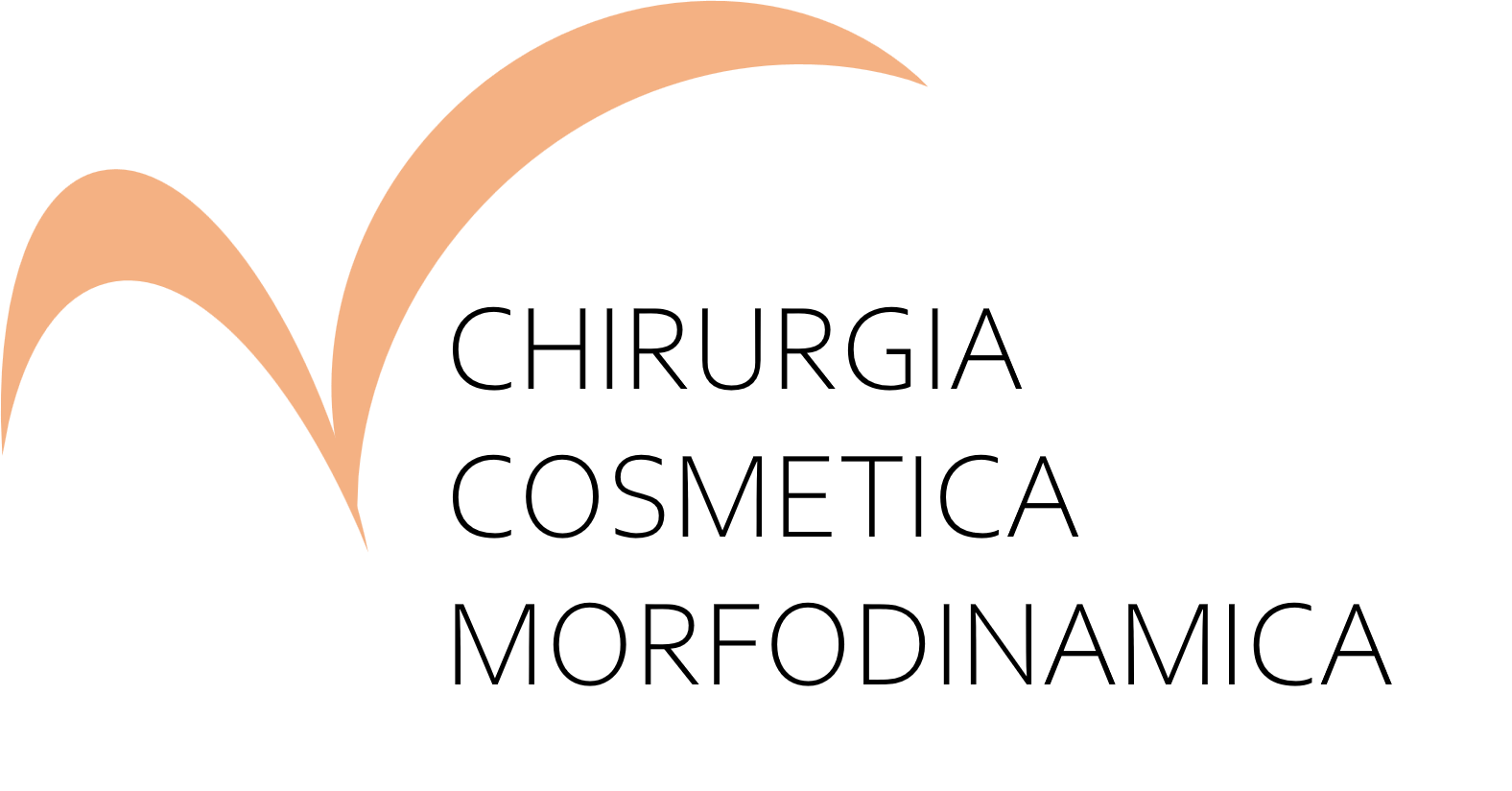Introduzione
La secchezza orale (xerostomia) e la secchezza oculare (dry eye) derivano tipicamente da un’insufficiente funzione delle ghiandole salivari e lacrimali. Cause comuni includono la Sindrome di Sjögren (SS), una malattia autoimmune con infiltrazione linfocitaria nelle ghiandole esocrine, e i danni post-radioterapia (ad esempio in pazienti trattati per tumori testa-collo).
Queste condizioni provocano un forte impatto sulla qualità di vita: la xerostomia si associa a carie, infezioni orali, difficoltà digestive, mentre la secchezza oculare causa irritazione corneale e deficit visivi.
I trattamenti attuali sono prevalentemente sintomatici (lacrime artificiali, salive artificiali, farmaci secretagoghi come pilocarpina) e spesso insufficienti nei casi gravi.
Negli ultimi anni, la ricerca si è focalizzata su strategie rigenerative innovative per ripristinare la funzione ghiandolare.
Di seguito presento una rassegna delle principali linee di intervento: terapie con PRP, con cellule staminali mesenchimali, terapie con esosomi/vescicole extracellulari, approcci di ingegneria tissutale (organoidi e bio-scaffold) e il ruolo emergente della meccanobiologia nella rigenerazione ghiandolare.
Plasma Ricco di Piastrine (PRP) e rigenerazione ghiandolare
Il PRP (Platelet-Rich Plasma) è un concentrato autologo di piastrine contenente fattori di crescita e citochine che favoriscono la rigenerazione tissutale (Marx, 2004). I granuli α piastrinici rilasciano molecole come PDGF, TGF-β, VEGF, IGF-1, EGF e bFGF, che stimolano angiogenesi, proliferazione cellulare e rimodellamento della matrice extracellulare.
Negli ultimi anni, il PRP è stato studiato anche come approccio rigenerativo per le ghiandole salivari e lacrimali:
- Xerostomia post-radioterapia: In pazienti irradiati per tumori testa-collo, iniezioni intraghiandolari di PRP hanno portato a un aumento significativo del flusso salivare non stimolato e a un miglioramento della qualità di vita (Alves et al., 2020).
- Sindrome di Sjögren: Alcuni studi preliminari suggeriscono che il PRP, grazie alla sua azione anti-infiammatoria e trofica, possa attenuare i sintomi oculari e orali della malattia. Rao et al. (2021) hanno osservato che instillazioni di PRP in forma di collirio nei pazienti con dry eye da Sjögren determinano un miglioramento dell’OSDI e del break-up time, oltre a una riduzione delle colorazioni corneali con fluoresceina.
- Dry eye non-Sjögren: Il collirio autologo a base di PRP è stato valutato in più trial clinici: Lopez-Plandolit et al. (2021) hanno dimostrato che in pazienti con cheratocongiuntivite secca il PRP topico riduce l’infiammazione della superficie oculare e aumenta i livelli di mucine protettive, con un miglioramento clinico duraturo.
- Meccanismi biologici: Il PRP agisce non solo rilasciando fattori di crescita, ma anche modulando l’immunità locale: in modelli animali di Sjögren, applicazioni di PRP hanno mostrato una riduzione delle citochine pro-infiammatorie (IL-1β, TNF-α) e una stimolazione della neoangiogenesi perivascolare (Chen, 2022). Inoltre, la componente fibrinica del PRP funge da micro-scaffold naturale, creando un ambiente pro-rigenerativo simile a quello sfruttato nei biomateriali bioattivi (Gentile, 2020; Gentile, 2020).
- Esperienza clinica e metodologica di Gentile: Pietro Gentile ha evidenziato che una concentrazione ottimale di piastrine (circa 1×10⁶ plt/µL) e un rapporto PRP/media ≤ 10% vol/vol risultano determinanti per massimizzare il potenziale rigenerativo del PRP in diversi tessuti (Gentile, 2020).
- Integrazione con strategie rigenerative esocrine: Sebbene al momento vi siano pochi studi specifici per le ghiandole salivari e lacrimali, il principio rigenerativo del PRP – lent release di fattori trofici combinato con supporto strutturale – lo rende un candidato potenziale per interventi intraghiandolari o topici nei distretti colpiti da secchezza orale/oculare.
In sintesi, il PRP rappresenta una strategia complementare o alternativa alle MSC ed esosomi: facilmente ottenibile, autologo e sicuro, può essere usato come iniezione intraghiandolare per la xerostomia o come collirio per la secchezza oculare. I dati attuali suggeriscono un effetto rigenerativo e sintomatico positivo, ma servono trial randomizzati di maggiori dimensioni per confermarne l’efficacia a lungo termine.
- Gentile P., Garcovich S., Bielli A., Scioli M.G., Orlandi A., Cervelli V. (2020). A PRP concentration of 1.0 × 10⁶ plt/µL appears to be optimal … Systematic Review. Intl J. Mol. Sci., 21(6):2143.
- Gentile P. (2015). The Effect of Platelet-Rich Plasma in Hair Regrowth: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Stem Cells Transl Med. 4(11):1317-1323.
- Marx R.E., Carlson E., et al. (2004). Platelet-rich plasma: growth factor enhancement for bone grafts. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 97(6):638-646.
Terapie basate su cellule staminali mesenchimali (MSC)
Le cellule staminali mesenchimali (MSC) – derivate da midollo osseo, tessuto adiposo o altre fonti – possiedono spiccate proprietà immunomodulatorie e capacità di differenziazione, risultando candidate promettenti per rigenerare le ghiandole salivari e lacrimali danneggiate. In modelli preclinici, il trapianto di MSC ha mostrato risultati significativi sia nel contesto autoimmune (Sjögren) sia dopo danno da radiazioni:
- Modelli animali – ghiandole salivari: Numerosi studi su topi hanno evidenziato che l’infusione o l’iniezione locale di MSC (da midollo osseo o adipose) dopo irradiazione delle ghiandole salivari migliora la funzione secretoria. Ad esempio, Lim et al. hanno dimostrato che MSC adipose umane, somministrate per via endovenosa subito dopo irradiazione in un modello murino, sono in grado di “homing” verso la ghiandola danneggiata ed engraftarsi, determinando entro 12 settimane un aumento significativo del flusso salivare, riduzione del ritardo di secrezione, e maggior produzione di mucina e amilasi rispetto ai controlli. Parallelamente, si osservava una diminuzione dell’apoptosi acinare e l’evidenza istologica che alcune MSC trapiantate esprimevano marcatori acinari (come l’α-amylase), segno di trans-differenziazione in cellule salivari.
- Analogamente, Kim et al. (studio 2020) hanno riportato che il trapianto xenogenico di MSC adipose umane dopo danno da iodio radioattivo nei topi stimola la rigenerazione: aumenta la densità di acini secreti di mucina, l’espressione di AQP5 (marcatore epiteliale acinare) e CD31 (endoteliale), riduce l’apoptosi e ripristina livelli di fattori come EGF e amilasi nella saliva. Importante, a 16 settimane dal trattamento le MSC umane risultavano ancora presenti nei tessuti murini rigenerati.
- Ulteriori esperimenti hanno documentato effetti benefici anche somministrando MSC direttamente intra-ghiandola subito dopo la lesione: iniezioni intraglandulari di MSC in ghiandole irradiate hanno portato a maggior flusso salivare, minor fibrosi e apoptosi e migliore vascolarizzazione rispetto a controlli non trattati.
- In un modello murino autoimmune di SS (topi NOD), la somministrazione di MSC ha ridotto l’infiltrato linfocitario nelle ghiandole, abbassando citochine infiammatorie (TNF-α, IL-1β, IL-17A) e aumentando citochine antinfiammatorie (es. IL-10), con conseguente recupero parziale della funzione secretoria. Complessivamente, nei modelli preclinici le MSC contribuiscono alla rigenerazione sia differenziandosi in elementi ghiandolari sia – soprattutto – tramite effetti paracrini: rilascio di fattori trofici, pro-angiogenici (VEGF, FGF-2) e immunomodulanti che stimolano le cellule residenti e l’ambiente riparativo. Ad esempio, Ahamad et al. hanno evidenziato che le MSC rilasciano segnali che aumentano l’espressione di canali del calcio e di acquaporina-5 nelle ghiandole irradiate, facilitando la ripresa della secrezione. Allo stesso modo, Saylam et al. hanno osservato che MSC allogeniche adipose, iniettate per via intraperitoneale in ratti con danno salivare da radioiodio, promuovono la rigenerazione a 6 mesi riducendo la fibrosi e preservando la struttura ghiandolare.
- Modelli animali – ghiandole lacrimali: Anche per le ghiandole lacrimali, ricerche precliniche mostrano risultati promettenti. In un modello murino di “dry eye” da rimozione chirurgica della ghiandola lacrimale, il trapianto di MSC ha accelerato il recupero della funzione: Hayashi et al. (Sci. Rep. 2019) hanno riportato un aumento della secrezione lacrimale e rigenerazione istologica della ghiandola dopo iniezione di MSC, con elevata espressione di marker acinari (AQP5, AQP4), marker mioepiteliali (α-SMA) e progenitori duttali (CK5) nei tessuti rigenerati. Questo era accompagnato da una proliferazione cellulare maggiore (Ki-67) e livelli elevati di fattori di crescita nel siero (EGF), coerenti con un miglioramento funzionale delle lacrime. Studi con MSC marcate (esprimenti eGFP) hanno evidenziato che le MSC infuse nelle ghiandole lacrimali vengono effettivamente rilevate nel tessuto nelle prime settimane, ma il loro numero declina col tempo, suggerendo che il beneficio derivi più dai fattori secreti che da una integrazione permanente delle cellule trapiantate. In effetti, analisi del secretoma di MSC lacrimali murine hanno identificato proteine bioattive (es. Lipocalina-2, prosaposina, Rac1, STAT1) che possono proteggere le cellule epiteliali lacrimali e favorirne la sopravvivenza.
- Inoltre, nei modelli di secchezza autoimmune (come topi NOD/SS), il trattamento con MSC riduce le infiltrazioni infiammatorie nella ghiandola lacrimale ~40%, sopprime macrofagi e TNF-α, e abbassa l’espressione di citochine pro-infiammatorie (TGF-β, IL-1β, IFN-γ, IL-17A) parallelemente a un aumento di IL-10 antinfiammatoria. Tali effetti immunomodulanti suggeriscono che le MSC aiutano a ristabilire la tolleranza immunitaria periferica, frenando l’attacco autoimmune alle ghiandole esocrine.
- Studi clinici nelle ghiandole salivari: La traduzione clinica delle terapie con MSC per xerostomia è ancora agli inizi, ma in espansione. Alcuni trial di fase I/II hanno valutato sicurezza ed efficacia di MSC autologhe in pazienti con danno ghiandolare post-radioterapia:
- Spaas et al. (2017) hanno somministrato MSC autologhe derivate da midollo osseo in pazienti con xerostomia severa post-RT, osservando a 3 mesi miglioramenti soggettivi negli score di qualità di vita e deglutizione in ~83% dei pazienti, insieme ad aumenti moderati nel flusso salivare non stimolato.
- Un altro studio pilota (MSC da tessuto adiposo, iniezione intraghiandolare) ha riportato assenza di eventi avversi seri e un trend di incremento della produzione salivare a 1 anno dal trattamento.
- Recentemente, Pringle et al. hanno condotto un trial di fase I dose-escalation con MSC midollari attivate con IFN-γ in pazienti post-RT: i risultati hanno indicato sicurezza e suggerito un possibile beneficio clinico, sebbene il miglioramento del flusso saliva fosse variabile e necessiti conferma in studi più ampi.
- Per Sjögren primario, in Cina sono stati effettuati studi pilota con infusioni endovenose di MSC allogeniche: una revisione sistematica (Wang et al., 2021) riporta che in quasi tutti i casi trattati si osserva un aumento della secrezione salivare e lacrimale e una riduzione dei livelli di fattori autoimmuni (es. IgG, RF) senza gravi effetti collaterali. Globalmente, le evidenze cliniche emergenti suggeriscono che la terapia con MSC è sicura e può apportare beneficio in termini di funzione ghiandolare (salivare e lacrimale) e in caso di sintomi di secchezza, sebbene permangano variabili legate al donatore (ad es. eventuali anticorpi anti-MSC sviluppati dal ricevente possono attenuare la risposta). Sono in corso trial controllati randomizzati per definire l’efficacia: ad esempio, uno studio randomizzato (NCT04620191) sta valutando MSC adipose allogeniche vs placebo in pazienti con xerostomia post-RT. Al momento, dunque, le MSC rappresentano una promettente opzione rigenerativa “personalizzata”, grazie alla loro capacità di modulare l’ambiente infiammatorio e potenzialmente rimpiazzare cellule ghiandolari perse.
Terapie a base di esosomi e vescicole extracellulari
Le MSC esercitano gran parte dei loro effetti terapeutici tramite fattori secreti, in particolare vescicole extracellulari (EV) come gli esosomi (nanovescicole di 30-150 nm). Gli esosomi veicolano molecole bioattive – mRNA, microRNA, proteine – e possono attraversare barriere biologiche grazie alle loro piccole dimensioni e al doppio strato lipidico. Ciò li rende una strategia di terapia “cell-free” attraente: si evitano i rischi associati alle cellule vive (ad es. potenziale tumorigenesi o reazioni immunitarie) pur conservando le proprietà immunomodulanti e rigenerative delle MSC. Negli ultimi anni sono emerse evidenze che gli esosomi derivati da MSC (MSC-Exos) possono migliorare la funzione delle ghiandole salivari e lacrimali in contesti di malattia autoimmune e danno, agendo su diversi meccanismi molecolari:
- Meccanismi molecolari: Gli esosomi da MSC contengono fattori anti-infiammatori e trofici che influenzano positivamente le cellule bersaglio. Ad esempio, studi hanno mostrato che in condizioni infiammatorie gli MSC-Exos possono indurre uno shift immunitario verso fenotipi tollerogenici: promuovono cellule dendritiche tollerogene, macrofagi di tipo M2 e linfociti T regolatori, mentre sopprimono sottopopolazioni effettrici (Th1, Th17). In modelli murini di Sjögren, Ma et al. (2021) hanno dimostrato che il trattamento con esosomi di MSC attenua le alterazioni patologiche nelle ghiandole salivari e lacrimali, frenando l’infiammazione linfocito-mediata e prevenendo la progressione della malattia.
- Un particolare interesse è rivolto ai microRNA veicolati: per esempio, esosomi MSC arricchiti in miR-125b sono risultati capaci di ridurre drasticamente la plasmacellularità patologica in modelli di SS, tramite il targeting di PRDM1 (gene chiave per la sopravvivenza delle plasmacellule). Ciò si traduce in minore produzione di autoanticorpi e minore danno autoimmune.
- Altri microRNA ed enzimi contenuti negli esosomi contribuiscono a bloccare vie infiammatorie (ad es. NF-κB, STAT1) e a promuovere fattori citoprotettivi. Oltre all’immunomodulazione, gli MSC-Exos forniscono fattori di crescita (EGF, bFGF, HGF, ecc.) che agiscono direttamente sulle cellule acinari residue: legandosi ai rispettivi recettori stimolano vie di segnalazione (PI3K/Akt, MAPK) che incrementano l’espressione di geni per componenti del film lacrimale e salivare. Ad esempio, EGF, HGF e FGF nei secretomi di MSC aumentano l’espressione di mucine e proteine salivari, mentre HGF attiva c-Met nelle cellule acinari proteggendole dall’apoptosi via Akt/FOXO. Sul versante lacrimale, gli esosomi hanno dimostrato di migliorare l’angiogenesi nella ghiandola infiammata (rilascio di VEGF, Ang-2) facilitando l’afflusso di nutrienti e cellule riparatrici. In sintesi, gli MSC-Exos agiscono su più fronti: riducono l’infiammazione locale, potenziano la rigenerazione vascolare e stimolano direttamente le cellule secernenti residue, aiutando a ripristinare la funzione esocrina.
- Modalità di somministrazione: Data la loro natura subcellulare, le vescicole extracellulari possono essere somministrate in modi flessibili. Negli occhi, si sono sperimentati colliri a base di esosomi: questa via topica sfrutta l’accesso diretto alla superficie oculare. Un recente studio clinico (fase I/II) ha testato gocce oculari di esosomi derivati da MSC del cordone ombelicale in pazienti con dry eye severo refrattario (inclusa secchezza di Sjögren). Dopo 2 settimane di trattamento bi-giornaliero, si sono osservati miglioramenti clinici significativi: riduzione dell’Ocular Surface Disease Index (OSDI) medio, aumento del menisco lacrimale e del test di Schirmer (produzione lacrimale), prolungamento del tempo di rottura del film lacrimale e diminuzione della colorazione corneale con fluoresceina. Questi benefici erano più marcati nei pazienti con secchezza non-Sjögren rispetto a quelli SS, ma presenti in entrambi i gruppi. Importante, non si sono registrati eventi avversi gravi, indicando un buon profilo di sicurezza. Parallelamente, sulle stesse coorti sono stati dosati marker lacrimali: dopo la terapia con esosomi si è riscontrata una riduzione delle citochine infiammatorie IL-6 e IL-17A nel film lacrimale, insieme a un aumento significativo di MUC5AC (mucina protettiva). Inoltre, analisi proteomiche delle lacrime hanno suggerito che il meccanismo d’azione è legato all’inibizione dell’infiammazione Th17-mediata.
- Un altro trial randomizzato recentemente pubblicato (Habibi et al., 2025) ha confrontato collirio ad esosomi MSC vs placebo in 16 occhi con dry eye associato a Sjögren: dopo 3 mesi, il gruppo trattato mostrava OSDI significativamente ridotto, aumento del volume lacrimale e miglioramento del break-up time corneale rispetto ai controlli. Nei campioni di lacrime trattate è stata rilevata un’impennata di proteine rigenerative come EGF e trombospondina-1, con concomitante forte calo di mediatori pro-infiammatori (IL-6, MMP-9). Questi dati confermano il potenziale terapeutico sostanziale degli esosomi topici per l’occhio secco SS-correlato, garantendo al contempo sicurezza e tollerabilità.
- Per le ghiandole salivari, la via più studiata in modelli animali è l’iniezione locale: ad esempio, Feng et al. (2020) hanno iniettato esosomi da MSC nella ghiandola sottomandibolare di topi irradiati, osservando un recupero del flusso salivare e rigenerazione acinare comparabile a quella ottenuta con MSC intere. Si stanno esplorando anche sistemi di rilascio controllato: gel termo-sensibili caricati con esosomi MSC da applicare localmente, o idrogel iniettabili nelle ghiandole, in modo da prolungare l’esposizione dei tessuti ai fattori benefici. Queste formulazioni mirano a trattenere le vescicole nel sito bersaglio e a proteggerle dalla degradazione, massimizzando l’effetto rigenerativo. Un ulteriore sviluppo sono gli spray o collutori contenti EV per la mucosa orale, ipotizzati come terapia facile per xerostomia (ancora in fase preclinica).
- Evidenze sperimentali e cliniche: Preclinicamente, come accennato, molte evidenze parallele a quelle delle MSC mostrano efficacia degli esosomi. In modelli murini di SS, il trattamento con esosomi ha eguagliato le MSC nel ridurre infiltrati linfocitari e autoanticorpi, ripristinando parzialmente la funzione salivare. Fan et al. (2020) hanno riportato che EV di MSC umane somministrati sistemicamente in topi NOD diminuivano le cellule T autoreattive e le plasmacellule nelle ghiandole, grazie a microRNA immunosoppressori, frenando la progressione della sindrome.
- Sul versante clinico, oltre ai colliri citati, si segnalano tentativi di utilizzare EV anche per la bocca secca: un piccolo studio pilota in Cina ha applicato spray di esosomi da MSC sulle mucose orali di pazienti SS, riscontrando dopo 4 settimane un miglioramento soggettivo dell’idratazione orale e un aumento del flusso salivare non stimolato (dati ancora preliminari, non pubblicati estensivamente). Nel complesso, le terapie con esosomi rappresentano un’evoluzione interessante: permettono di somministrare solo i “messaggi” rigenerativi delle MSC, riducendo i rischi cellulari e potenzialmente potendo standardizzare il prodotto (dose di proteine/vescicole definita). Le sfide restano nella produzione su larga scala di esosomi purificati e nella loro conservazione efficace. Tuttavia, le ricerche attuali (2020-2025) suggeriscono che gli esosomi MSC possono divenire una nuova frontiera terapeutica per le secchezze oculari e orali severe, agendo attraverso una modulazione fine dell’ambiente immune e la stimolazione diretta delle cellule ghiandolari residuali.
Tecniche di ingegneria tissutale delle ghiandole salivari e lacrimali
Un altro filone rigenerativo di grande rilievo è l’ingegneria tissutale, che mira a ricostruire tessuti ghiandolari funzionali in laboratorio da trapiantare nel paziente. Vista la complessità architetturale delle ghiandole salivari e lacrimali (unità acinari secernenti, reti di dotti, innervazione e vascolarizzazione fine), le strategie comprendono l’uso di scaffold biomimetici, organoidi derivati da cellule staminali, tessuti decellularizzati e approcci di bio-stampa 3D. Di seguito, i progressi chiave:
- Organoidi e sferoidi ghiandolari: Gli organoidi sono micro-tessuti tridimensionali coltivati in vitro che riproducono la struttura e la funzione di un organo in miniatura. Per le ghiandole salivari, organoidi sono stati generati a partire da cellule staminali/progenitrici delle stesse ghiandole. Ad esempio, Nanduri et al. (2014) hanno isolato cellule staminali duttali dalle ghiandole salivari umane e le hanno coltivate in Matrigel con FGF10, ottenendo entro 2 settimane organoidi esprimenti marcatori specifici come AQP5 (marcatore acinare di secrezione) e Mist1 (fattore di trascrizione acinare). Questi “mini-salivari” hanno dimostrato capacità secretorie in vitro. Un aspetto cruciale è la presenza di segnali mesenchimali: infatti, combinando organoidi epiteliali salivari con cellule mesenchimali embrionali (da topi E12.5), Miyajima et al. (2011) hanno ottenuto germogli di ghiandola salivare che, una volta trapiantati in topi sottomessi a scialoadenectomia, si sono integrati con i dotti del ricevente e hanno prodotto saliva. L’analisi istologica post-trapianto ha confermato che le ghiandole bioingegnerizzate presentavano struttura normale e componenti secretori tipici (enzimi salivari, mucine). Questo metodo del “germe d’organo” è stato applicato con successo anche per le ghiandole lacrimali: cellule epiteliali e mesenchimali da embrioni murini co-coltivate hanno formato gemme lacrimali ramificate, che trapiantate in topi privi di ghiandola lacrimale hanno ricostituito un apparato secernente connesso al dotto escretore ospite. I topi engraftati producevano lacrime contenenti latttoferrina e lipidi tipici, proteggendo la superficie oculare (assenza di assottigliamento corneale rispetto a topi non trattati). Questo risultato rappresenta un proof-of-concept importante: organoidi ghiandolari generati ex vivo possono attecchire e ripristinare la funzione in vivo.
- Trapianto di cellule/progenitori e organoidi: Oltre ai germi d’organo embrionali, si è tentato il trapianto di organoidi derivati da tessuti adulti. Klein et al. (2019) hanno dimostrato che organoidi da cellule progenitrici di ghiandola sottomandibolare murina, una volta impiantati in topi precedentemente irradiati, ricostruiscono la funzione salivare: le ghiandole riceventi mostravano recupero di produzione salivare a lungo termine e integrazione vascolare e nervosa degli organoidi trapiantati. Similmente, cellule staminali derivate da ghiandole salivari umane (labiali) sono state testate in un modello xenogenico: Pringle et al. (2018) hanno iniettato cellule staminali salivari umane in ghiandole irradiate di topi, osservando che queste formavano strutture simili ad acini e contribuivano al ripristino parziale della salivazione. Un aspetto interessante è la resistenza alle radiazioni: organoidi derivati da cellule di parotide murina hanno mostrato tolleranza a dosi di irradiazione che in vivo distruggerebbero la ghiandola, suggerendo che gli organoidi possano essere usati come sistema di screening per terapie radioprotettive e come riserva di tessuto per autotrapianti post-RT. Nel campo lacrimale, Jeong et al. (2023) hanno sviluppato organoidi da ghiandola lacrimale umana: partendo da tessuto lacrimale di donatori, hanno ottenuto strutture 3D che esprimono marcatori acinari e secernono componenti delle lacrime (lisozima, lattotransferrina, mucina-5AC). Questi organoidi rispondono a stimoli colinergici (pilocarpina) aumentando il calcio intracellulare e la secrezione, mimando la fisiologia ghiandolare. Importante, trapiantando organoidi lacrimali di topo (esprimenti GFP) in topi con dry eye autoimmune, si è osservato l’attecchimento delle strutture trapiantate nella ghiandola ricevente e la loro persistenza a 2 settimane, come indicato da cellule GFP+ e dalla espressione di AQP5 nel tessuto ricevente. Si è visto inoltre che per il successo degli organoidi lacrimali sono cruciali alcuni fattori: l’espressione di EpCAM (marcatore epiteliale) è necessaria perché le cellule formino organoidi, e il fattore di sviluppo oculare PAX6 è importante per una proliferazione organoide ottimale (sua assenza riduce la crescita).
- Scaffold biomimetici e costrutti bioingegnerizzati: La ricostruzione di ghiandole ex vivo spesso richiede supporti 3D su cui far crescere le cellule. Sono stati sviluppati scaffold decellularizzati da ghiandole o da altri tessuti: Lin et al. (2016) hanno usato ghiandole lacrimali di coniglio decellularizzate come impalcatura naturale su cui seminare cellule di ghiandola lacrimale: le cellule attecchiscono e proliferano, mantenendo la struttura acino-ductale grazie all’ECM nativa. Un altro esempio è l’uso di sottomucosa intestinale suina decellularizzata (SIS): Naqvi et al. (2018) hanno mostrato che la SIS decellularizzata funziona da scaffold per cellule epiteliali di ghiandola lacrimale, supportandone la sopravvivenza e organizzazione in acini secernenti. Interessante, la SIS conservava vasi sanguigni residui che potevano essere ricolonizzati da cellule endoteliali, migliorando così la funzionalità e suggerendo la possibilità di pre-vascolarizzare il costrutto. L’aggiornamento più recente di questo lavoro ha permesso di aumentare il numero di cellule coltivate sullo scaffold, portando il tessuto ingegnerizzato a dimensioni più vicine a quelle necessarie per uso clinico. Per le ghiandole salivari, sono stati provati scaffolds sintetici come idrogel di fibrina o Matrigel con cellule salivari coltivate in 3D: queste formano strutture sferoidali che esprimono marcatori funzionali (α-amylase, ZO-1, mucine). Alcuni studi hanno esplorato anche la tecnica dei “cell sheet”: usare fogli continui di cellule acinari coltivate su supporti termosensibili, poi impiantati sulla ghiandola danneggiata (modellando il tessuto in loco). I risultati in modelli murini indicano che i “cell sheet” di cellule salivari possono integrarsi con il tessuto ospite e migliorare la secrezione, offrendo un’alternativa ai singoli cluster cellulari.
- Biostampa 3D e tecnologie avanzate: La stampa 3D applicata ai tessuti biologici (bioprinting) sta emergendo anche per le ghiandole esocrine. Una tecnica interessante è la stampa 3D magnetica: cellule salivari (epiteliali, mioepiteliali, neuronali) vengono etichettate con nanoparticelle magnetiche biocompatibili e disposte tramite campi magnetici in aggregati 3D ordinati. Tang et al. (2018) sono riusciti a stampare in questo modo organoidi di ghiandola salivare contenenti strutture secernenti innervate; tali organoidi bio-stampati, dopo differenziazione in vitro, presentavano oltre il 90% di cellule vitali a 3 giorni. Una volta trapiantati in topi con ghiandole irradiate, questi costrutti stampati hanno stimolato la rigenerazione locale: si è osservata una maggiore proliferazione dell’epitelio residuo e una reinnervazione del tessuto, segni che il costrutto favoriva il ripopolamento funzionale. Questo risultato apre la strada all’uso della biostampa per creare ghiandole su misura, includendo anche componenti neuronali per un recupero completo della funzione (che dipende molto dall’innervazione autonomica). Un altro approccio futuristico riguarda l’integrazione nei tessuti ingegnerizzati di sensori/elettronica flessibile: si stanno sviluppando “mesh electronics” – reti di elettrodi flessibili e biocompatibili – da inserire nei costrutti ghiandolari. Questi dispositivi, finissimi e non immunogeni, possono essere impiantati insieme al tessuto bioingegnerizzato per monitorarne l’attività elettrica o persino fornire stimoli neuronali artificiali. Studi preliminari mostrano che tali mesh possono misurare l’attività e stimolare la secrezione in organoidi salivari in laboratorio, e in futuro potrebbero aiutare a reinnervare le ghiandole trapiantate fornendo segnali elettrici analoghi a quelli nervosi.
In sintesi, l’ingegneria tissutale delle ghiandole salivari e lacrimali ha compiuto passi notevoli: dalla generazione di mini-organi funzionali in vitro (organoidi, germogli d’organo) al loro impianto con successo in modelli animali, fino a scaffolds innovativi e bioprinting. Le sfide rimangono nel tradurre questi risultati all’uomo: bisogna ottenere organoidi da cellule umane autologhe (o da iPSC, cellule staminali pluripotenti indotte) di qualità sufficiente. A tal proposito, va segnalato che sono stati creati organoidi lacrimali a partire da cellule iPS umane: un gruppo nel 2022 ha usato una coltura “multi-zona” dove iPSC differenziavano in vari tipi di ectoderma oculare, generando cluster che esprimevano marcatori lacrimali e producevano proteine delle lacrime (lisozima, lactoferrina). Anche se ancora poco efficienti, questi approcci iPSC aprono alla possibilità di creare ghiandole “ex novo” per pazienti che non hanno tessuto residuo da cui partire. Infine, resta fondamentale garantire la vascolarizzazione dei tessuti bioingegnerizzati una volta trapiantati: oltre a pre-vascolarizzare gli scaffold (come con SIS decellularizzata), si studiano strategie come il rilascio di fattori angiogenici o la co-coltura con cellule endoteliali per assicurare un rapido attecchimento del tessuto trapiantato.
Ruolo della Meccanobiologia nella rigenerazione ghiandolare
La Meccanobiologia gioca un ruolo fondamentale nella Medicina Rigenerativa e nella Chirurgia Cosmetica Morfodinamica: composizione e consistenza della matrice, stimoli meccanici di tensione, pressione idrostatica, trazione, come anche stimoli ultrasonici e segnali elettrici modulano la differenziazione cellulare e la secrezione (Rizzo, 2024).
Questo recente ed innovativo campo di indagine si riferisce all’insieme dei segnali meccanici e delle proprietà fisiche del microambiente che influenzano il comportamento cellulare. Nelle ghiandole salivari e lacrimali, fattori meccanici come la rigidità della matrice extracellulare, le sollecitazioni da flusso di fluido, la pressione esercitata dai dotti e la presenza di stimoli fisici esterni (es. blanda manipolazione, ultrasuoni, impulsi elettrici) possono avere un impatto significativo sulla rigenerazione e sul mantenimento della funzione. Negli ultimi anni si è compreso che modulare questi aspetti può migliorare le terapie rigenerative:
- Rigidità e composizione della matrice: Durante lo sviluppo e la rigenerazione delle ghiandole, l’interazione epitelio-mesenchima è mediata anche dalla consistenza del tessuto. Studi in vitro hanno mostrato che una matrice troppo rigida può ostacolare la morfogenesi ghiandolare. In un esperimento classico, Larsen et al. (2014) hanno coltivato abbozzi di ghiandola salivare murina su gel con diversa rigidità (elasticità 0,5 kPa vs 20 kPa): sui gel più rigidi, le ghiandole hanno mostrato ramificazione ridotta e differenziamento aberrante, con perdita di marker acinari (AQP5) e mioepiteliali (α-SMA). Al contrario, gel morbidi (simili alla compliance fisiologica) permettevano un’organizzazione normale e l’espressione corretta dei marcatori differenziativi. Interessante, il fenomeno era in parte reversibile: trasferendo le ghiandole da un substrato rigido a uno morbido, si osservava un recupero dell’architettura acinare, segno che uno stimolo meccanico adeguato può “rescue” il programma morfogenetico.
- A livello molecolare, la rigidità eccessiva attiva vie di segnalazione mechano-sensoriali: la tensione cellulare causa l’attivazione di integrine e del complesso FAK-ROCK, che porta alla traslocazione di fattori come YAP/TAZ nel nucleo, alterando l’espressione genica. Inoltre, un tessuto rigido facilita l’attivazione del TGF-β latente: le forze di trazione liberano TGF-β dal suo complesso di latenza, innescando la cascata SMAD pro-fibrotica. Questo spiega perché nelle ghiandole cronicamente infiammate e fibrotiche (come nella Sjögren avanzata) il microambiente meccanico rigido perpetua il danno, promuovendo differenziazione dei fibroblasti in miofibroblasti via miR-21 e miR-29 indotti dalla stiffness. In ottica rigenerativa, quindi, scaffold bioattivi a rigidità controllata sono cruciali: l’ideale è fornire un supporto con elasticità simile al tessuto nativo (nell’ordine di pochi centinaia di Pascal per le ghiandole). Idrogel innovativi, come quelli a base di acido ialuronico o alginate cross-linkate Ca²⁺, possono essere regolati in rigidità e hanno mostrato di sostenere meglio la sopravvivenza delle cellule salivari rispetto a materiali rigidi. Anche l’architettura nanofibrosa dello scaffold incide: studi hanno visto che modifiche delle fibre (es. aggiunta di chitosano su nanofibre di PLGA) alterano la polarizzazione delle cellule salivari coltivate, influendo sulla corretta localizzazione delle giunzioni serrate (ZO-1) e quindi sulla formazione di lume acinare. Ciò evidenzia che la microstruttura e le proprietà meccaniche del materiale di supporto possono orientare la rigenerazione verso esiti migliori, fornendo segnali analoghi a quelli che le cellule percepiscono in un tessuto sano.
- Stimoli meccanici esterni – Ultrasuoni: L’applicazione di ultrasuoni terapeutici a bassa intensità è emersa come metodo per stimolare la rigenerazione tissutale in vari distretti (osso, muscolo, etc.), incluse le ghiandole salivari. Il cosiddetto LIPUS (Low-Intensity Pulsed Ultrasound) produce micro-vibrazioni e stimoli acustici non termici che le cellule percepiscono come segnali meccanici. Xu et al. (2015) hanno mostrato in un modello murino di scialoadenite autoimmune (topi MRL/lpr, modello di Sjögren) che trattamenti quotidiani con LIPUS sulle ghiandole salivari infiammate portavano a un ripristino della secrezione salivare ai livelli normali dei topi sani. Meccanisticamente, LIPUS esercita un effetto anti-infiammatorio locale: nello studio, si è visto che gli ultrasuoni pulsati inibivano la via NF-κB nelle cellule acinari e duttali salivari, aumentando l’espressione di A20 (proteina regolatoria che frena NF-κB) e riducendo quella di mediatori infiammatori come COX-2 e TNF-α. I topi trattati con LIPUS presentavano meno infiltrati immuni nelle ghiandole e maggior espressione di aquaporina-5 (AQP5), il canale dell’acqua chiave per la secrezione salivare. Inoltre, LIPUS sembra poter compensare il declino secretorio legato all’età nei topi MRL/lpr più anziani, riportando la portata salivare a valori giovanili. Questo suggerisce che gli ultrasuoni possano agire sia sull’infiammazione autoimmunitaria sia su alterazioni epigenetiche (come l’ipermetilazione di AQP5 che avviene con l’età). Dal punto di vista clinico, gli ultrasuoni a bassa intensità sono una terapia fisica attraente perché non invasiva e con effetti collaterali minimi. Pur essendo necessarie ulteriori conferme (ad esempio trial clinici dedicati a LIPUS in pazienti con Sjögren o xerostomia post-RT), questi risultati iniziali indicano che la stimolazione meccanica ultrasonica può attivare vie cellulari pro-rigenerative (proliferazione, secrezione di AQP5) e ridurre i segnali pro-infiammatori nelle ghiandole, aiutando a preservare e recuperare la funzione. In futuro, l’ultrasuono potrebbe essere combinato alle terapie cellulari (ad esempio, LIPUS sul sito di iniezione di MSC per potenziarne l’effetto).
- Stimoli elettrici e neuro-stimolazione: Le ghiandole salivari e lacrimali sono fortemente dipendenti dalla stimolazione nervosa autonoma per la secrezione. Pertanto, approcci di elettrostimolazione puntano a sfruttare i circuiti nervosi residui o a attivarne di nuovi. Una tecnica sperimentata è la TENS (Stimolazione Elettrica Nervosa Transcutanea) mirata ai nervi salivari. In uno studio clinico recente (Ros-Madrid & Lopez-Jornet, 2025), pazienti anziani con xerostomia sono stati trattati con TENS tramite elettrodi applicati esternamente: dopo tre sessioni, si è osservato un miglioramento progressivo con riduzione dei punteggi di secchezza soggettiva (VAS) e un aumento significativo del flusso salivare misurato (da 7,5 a 6,8 nella VAS, e corrispondente incremento nella sialometria). Un altro studio su un dispositivo di elettrostimolazione intraorale del nervo linguale (che innerva le ghiandole salivari submandibolari) ha riportato in una serie di casi un recupero della salivazione e sollievo dai sintomi di xerostomia severa. Questi dispositivi agiscono inviando impulsi elettrici a bassa intensità che attivano riflessi secretori attraverso i gangli parasimpatici, “sfruttando” le strutture nervose rimaste intatte. Dal lato lacrimale, sono in sviluppo piccoli elettrodi da posizionare nel fornice congiuntivale per stimolare il nervo lacrimale: l’idea è di emettere micro-impulsi coordinati che inducano la secrezione riflessa di lacrime. In modelli animali, questa neurostimolazione mirata ha prodotto un incremento del volume lacrimale e una maggiore espressione di enzimi lacrimali.
- Scaffold e materiali “stimolabili”: La meccano-biologia include anche materiali intelligenti che rispondono a stimoli fisici. Un esempio sono i materiali piezoelettrici: polimeri che generano piccole correnti elettriche se sottoposti a deformazione meccanica (ad es. vibrazioni da ultrasuoni). Integrando tali materiali in uno scaffold, è possibile che gli ultrasuoni applicati esternamente vengano convertiti in micro-segnali elettrici locali che stimolino le cellule (simulando l’effetto dell’innervazione). Allo stesso modo, nanomateriali conduttivi come i nanotubi di carbonio sono stati incorporati in idrogel per creare scaffold elettricamente attivi: questi nanotubi possono promuovere la crescita degli assoni nervosi e la riparazione nervosa grazie alla loro conduttività e proprietà meccaniche. Nella rigenerazione ghiandolare, tali scaffold conduttivi potrebbero facilitare la ricolonizzazione nervosa delle ghiandole bioingegnerizzate o anche trasmettere segnali elettrici esterni alle cellule epiteliali, migliorandone la funzionalità secretoria. Studi di neurobiologia rigenerativa hanno mostrato che i nanotubi di carbonio supportano la ricrescita di nervi periferici lesionati e aumentano la velocità di rigenerazione assonale. Applicati a un contesto di ghiandole salivari, ciò potrebbe tradursi in una migliore reintegrazione funzionale post-trapianto. Un altro aspetto meccano-biologico riguarda la forza di taglio (shear stress) durante la somministrazione cellulare: quando si iniettano cellule o organoidi, lo stress meccanico può causare danno cellulare. Per ovviare, si stanno sviluppando biomateriali “shear-thinning”, ossia gel la cui viscosità diminuisce sotto stress (rendendo l’iniezione più dolce) e poi ritorna solida a destinazione. Alcuni idrogel a base di ialuronato o alginato posseggono questa proprietà: formano un rivestimento lubrificante sulla siringa durante l’iniezione riducendo l’attrito e la forza esercitata sulle cellule, che così arrivano vive in maggior numero nel sito bersaglio. Questo miglioramento “meccanico” del delivery si è dimostrato utile per aumentare la sopravvivenza delle MSC iniettate nelle ghiandole e potenzialmente l’efficacia terapeutica.
In conclusione, la meccano-biologia offre strumenti addizionali per ottimizzare la rigenerazione ghiandolare: creare un ambiente fisicamente favorevole (morbido, elastico, con segnali dinamici appropriati) è tanto importante quanto fornire le giuste cellule o fattori. Interventi come la modulazione della rigidità tissutale (ad es. tramite enzimi che digeriscono l’eccesso di collagene fibrotico), l’utilizzo di scaffold che mimano la meccanica nativa, e l’applicazione di stimoli fisici (ultrasuoni, elettrostimolazione) possono sinergizzare con le terapie cellulari e bioingegneristiche per massimizzare il recupero funzionale delle ghiandole salivari e lacrimali. Sebbene molti di questi approcci siano ancora in fase sperimentale, i progressi dal 2020 ad oggi delineano un futuro in cui potremo “allenare” meccanicamente le ghiandole a rigenerarsi e funzionare nuovamente, restituendo ai pazienti sollievo da secchezza orale e oculare refrattaria.
- Rizzo A. (2024). Meccanobiologia. Chirurgia Cosmetica Morfodinamica. [on line] August. Available at: https://www.chirurgiacosmeticamorfodinamica.it/2024/05/20/meccanobiologia/
- Rizzo A. (2025). The Role of Medhanobiology in Regenerative Aesthetic Medicine and Morphodynamic Cosmetic Surgery. [on line] setember. Available at: https://www.chirurgiacosmeticamorfodinamica.it/2025/10/21/the-role-of-mechanobiology-in-regenerative-aesthetic-medicine-and-morphodynamica-cosmetic-surgery-mdcs/
Conclusioni e prospettive
Le strategie rigenerative per le ghiandole salivari e lacrimali hanno compiuto notevoli avanzamenti negli ultimi anni (2020-2025). Terapie cellulari con MSC si sono rivelate promettenti nel riparare i danni da Sjögren e radioterapia grazie a un mix di capacità immunosoppressive e supporto trofico alle cellule epiteliali residue. Le scoperte sui meccanismi paracrini hanno portato allo sviluppo di terapie “cell-free” con esosomi ed EV, già testate con successo in modelli animali e in primi trial clinici (specialmente per l’occhio secco) con miglioramenti tangibili della secrezione e della salute dei tessuti. Parallelamente, l’ingegneria tissutale sta aprendo la possibilità di sostituire intere ghiandole: organoidi salivari e lacrimali umani sono in sviluppo, e se combinati con scaffolds avanzati e tecniche di bioprinting potrebbero fornire innesti funzionali per pazienti che hanno perso completamente il tessuto ghiandolare. Infine, la meccano-biologia aggiunge un ulteriore livello di intervento: comprendere e sfruttare i segnali fisici (forze meccaniche, stimoli acustici ed elettrici) permette di creare un microambiente pro-rigenerativo e di integrare meglio le terapie biologiche.
Guardando al futuro, possiamo immaginare approcci combinatori: ad esempio, usare scaffold biomimetici caricati con esosomi MSC, attivati da ultrasuoni periodici per rilasciare fattori on-demand; oppure trapiantare organoidi ingegnerizzati insieme a dispositivi di neurostimolazione per garantire sin da subito la funzione secretoria. Inoltre, lo sviluppo di marker e imaging avanzato aiuterà a monitorare l’attecchimento e la funzionalità dei rigenerati in tempo reale, guidando le terapie post-trapianto (come la stimolazione meccanica mirata). Le patologie di secchezza severa, come la Sindrome di Sjögren resistente, potrebbero in un prossimo futuro beneficiare di combinazioni di queste strategie, restituendo ai pazienti non solo sollievo sintomatico ma la vera rigenerazione delle loro ghiandole esocrine. La strada verso l’applicazione clinica routinaria richiede ancora studi più ampi e standardizzazione (in particolare per la produzione di EV e organoidi su larga scala), ma i risultati ad oggi ottenuti sono incoraggianti. In conclusione, le strategie rigenerative – dalle MSC agli esosomi, dagli organoidi agli ultrasuoni – rappresentano un cambio di paradigma nella gestione di xerostomia e dry eye, mirando a ripristinare la funzione biologica delle ghiandole colpite invece di limitarsi a gestirne i sintomi.
Bibliografia
- Marinkovic M. et al. (2025). Autologous mesenchymal stem cells offer a new paradigm for salivary gland regeneration. International Journal of Oral Science, 15(1):18.
- Harrell C.R. et al. (2024). Targeted Therapy for Severe Sjögren’s Syndrome: A Focus on Mesenchymal Stem Cells. International Journal of Molecular Sciences, 25(24):13712.
- Harrell C.R. et al. (2024). Molecular mechanisms responsible for mesenchymal stem cell-dependent attenuation of dry eye inflammation. Diseases, 12(11):269.
- Lieu A.C. et al. (2024). Approaches to Restoring Lacrimal Gland Function: From Stem Cells to Tissue Engineering. Current Ophthalmology Reports, 12(4):55-62.
- Habibi A. et al. (2025). Efficacy of topical mesenchymal stem cell exosome in Sjögren’s syndrome-related dry eye: a randomized clinical trial. BMC Ophthalmology, 25:299.
- Zhang D. et al. (2025). Umbilical cord mesenchymal stem cell eye drops for refractory Sjögren and non-Sjögren dry eye disease: a pilot trial. Stem Cell Research & Therapy, 16:202.
- Ros-Madrid J.F. & Lopez-Jornet P. (2025). Clinical study on the efficacy of TENS in patients with xerostomia. Applied Sciences, 15(5):2723.
- Xu J. et al. (2015). Low-intensity pulsed ultrasound rescues insufficient salivary secretion in autoimmune sialadenitis. Arthritis Research & Therapy, 17:278.
- Tang R. et al. (2018). Engineering innervated secretory epithelial organoids by magnetic 3D bioprinting for salivary gland regeneration. Biomaterials, 180:52-66.
- Nanduri L.S.Y. et al. (2014). Salivary gland stem cells and organoids for gland regeneration. Stem Cell Reports, 3(6):957-968.
- Lin B. et al. (2016). Hydrogels as extracellular matrix for 3-D culture of lacrimal gland cells. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 57(12): Oct 2016 (ARVO Meeting Abstract).
- Pringle S. et al. (2018). Human salivary gland stem cells repair radiation damage in a mouse model of xerostomia. Stem Cells, 36(2):199-210.